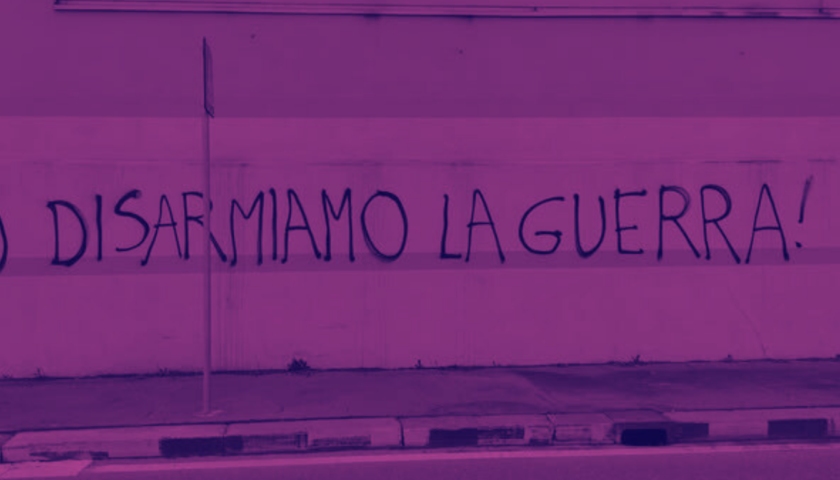La celebrata storia dell’Esercito italiano annovera numerose quanto ingloriose sconfitte: da Adua (1896) a Sciara Sciat (1911), da Guadalajara (1937) ad El Alamein (1942), sino alla dissoluzione militare dell’8 settembre 1943, ma sicuramente quella che, ancora a cento anni di distanza, mantiene la maggiore rilevanza simbolica e politica è senz’altro la disfatta di Caporetto, nell’ottobre 1917, ossia lo sfondamento del fronte da parte delle truppe degli Imperi Centrali che, soltanto nel primo giorno, penetrarono per venti chilometri in territorio italiano.
La celebrata storia dell’Esercito italiano annovera numerose quanto ingloriose sconfitte: da Adua (1896) a Sciara Sciat (1911), da Guadalajara (1937) ad El Alamein (1942), sino alla dissoluzione militare dell’8 settembre 1943, ma sicuramente quella che, ancora a cento anni di distanza, mantiene la maggiore rilevanza simbolica e politica è senz’altro la disfatta di Caporetto, nell’ottobre 1917, ossia lo sfondamento del fronte da parte delle truppe degli Imperi Centrali che, soltanto nel primo giorno, penetrarono per venti chilometri in territorio italiano.
«Nella fine delle fini», usando le parole di Carlo Emilio Gadda, il mondo dell’interventismo, delle trincee, dell’obbedienza venne capovolto e non sarebbe più stato quello di prima.
Nel corso del tempo ed anche in occasione di questo centenario, non sono mancate interpretazioni storiografiche che, stante l’innegabile rovescio militare e il collasso civile, hanno cercato di evidenziare aspetti positivi di quella sconfitta, quale male necessario per l’acquisizione di una nuova e più sentita coscienza nazionale, nonché il momento di svolta che avrebbe consentito la ripresa morale e la successiva offensiva delle forze armate italiane, con l’epilogo vittorioso di Vittorio Veneto.
Se allora la finalità propagandistica era scontata per motivare quell’unione sacra patriottica che si realizzò dalla destra nazionalista sino al socialismo riformista, oggi appare come l’ennesimo utilizzo politico della storia finalizzato alla ricostruzione di un’identità nazionale da spendere nell’attuale accelerazione militare dei conflitti economici e delle relazioni internazionali.
Tale rilettura appare sostanzialmente nipote dell’enfasi patriottica dell’epoca e sul piano storico poco fondata perché, di fatto, lo Stato italiano e i comandi militari dopo tale sconfitta furono costretti a mutare tattiche belliche, piani strategici e le stesse politiche d’impiego delle truppe, sia per ragioni d’economia umana sia per il timore di una non più recuperabile frattura disciplinare e gerarchica tra i soldati in prima linea, ma anche per l’ordine pubblico nelle città che preoccupava per ciò che era già avvenuto a Torino.
Non è questa la sede per ricostruire le fasi e gli errori che portarono nell’ottobre 1917 alla rottura del fronte orientale da parte di reparti tedeschi e austro-ungarici ed alla conseguente perdita e occupazione dei territori friulani e veneti sino al Piave; ma può essere indicativo riportare qualche dato riguardante i costi di quella sconfitta che, non casualmente, era stata preceduta dalle undici cruentissime battaglie sull’Isonzo ordinate dal gen. Luigi Cadorna, secondo quanto previsto dal suo micidiale manuale “Attacco frontale e ammaestramento tattico”.
Dal 1915 le undici «spallate» erano costate ufficialmente: 77.048, morti, 375.889 feriti e 128.883 dispersi tra i reparti italiani mandati inutilmente al massacro e dissanguatisi nella conquista di «Gorizia maledetta».
Il prezzo aggiuntivo della battaglia di Caporetto fu, in termini umani, di 11 mila morti, 29 mila feriti, 300 mila prigionieri e 350 mila tra sbandati e disertori; tra quest’ultimi sono stati approssimativamente stimati 5 mila fucilati.
Non meno gravi le perdite di materiale bellico, finito in mani nemiche: 3.152 pezzi d’artiglieria con circa 1.500.000 proiettili, 1.732 bombarde, 3.000 mitragliatrici, 2.000 pistole-mitragliatrici, 300.00 fucili (oltre a quelli dei prigionieri e degli sbandati), 73.000 quadrupedi, 150 aeroplani e 22 campi d’aviazione.
Ingenti anche i quantitativi di generi alimentari e vestiario andati perduti: 5 milioni di scatolette di carne, 700 mila di salmone, 27 mila quintali di gallette, 13 mila quintali di pasta, 7.200 quintali di riso, 2.530 quintali di caffè, 4.900 ettolitri di vino, 672 mila camicie, 673 mila mutande, 430 mila paia di pantaloni, 823 mila di calze, 321 mila di scarpe.
Come è noto, i comandi dell’esercito per scaricare le proprie funeste responsabilità (in particolare, relativa al mancato impiego dell’artiglieria) e gli errori militari compiuti, indicare quali cause della sconfitta la viltà e il tradimento delle truppe, nonché il ruolo deleterio svolto, al fronte e all’interno del paese, dalla propaganda disfattista, antimilitarista e pacifista svolta da socialisti, anarchici e cattolici, in nome dell’internazionalismo o dell’umana fratellanza.
Era un copione noto, così come fu sottolineato sull’Avanti!: «il disastro di Caporetto è una copia conforme a quelli di Adua e di Sciara Sciat per la identica insipienza dei nostri grandi uomini di guerra (…) i generali “revolveratori” di Caporetto non sono che la riproduzione dei generali “eroi del capestro” di Sciara Sciat».
Nei confronti dei cedimenti e dello sbandamento dei reparti furono mobilitati in funzione repressiva i carabinieri e la cavalleria sotto al guida spietata del generale Andrea Graziani, con rastrellamenti e fucilazioni sommarie, mentre Eugenio Filiberto di Savoia, comandante della III Armata, il 27 ottobre dette ordine affinché «artiglierie e mitragliatrici, appositamente scaglionate, sparino sui fuggiaschi».
Ben più che all’eroismo, grazie a tale regime del terrore e, soprattutto, in conseguenza dell’esaurirsi della spinta offensiva nemica, il fronte italiano – ridottosi di circa duecento chilometri – riuscì a “tenere” sulla linea del Piave.
Ma, aldilà dell’evocato «sciopero militare» e dell’eco entusiasmante della rivoluzione russa, anche se l’attività sovversiva e l’agitazione antibellicista, seppure svolte in modo frammentario, si erano incontrate con la diffusa insubordinazione spontanea, la migliore propaganda contro la guerra di fatto era stata proprio il «terribile carnaio umano» vissuto al fronte, così come la miseria per i ceti popolari, le requisizioni nelle campagne e la militarizzazione del lavoro in fabbrica.
Per questo, il 4 ottobre 1917 era stato emanato il “decreto Sacchi” che deferiva ai Tribunali militari anche i civili accusati di “disfattismo”: non solo gli scioperi furono considerati illegittimi, ma venne giudicato reato qualunque manifestazione che ostacolasse la produzione.
A tutto ciò si aggiunse il dramma delle popolazioni del nordest direttamente coinvolte e travolte dagli eventi della “guerra totale”, dopo aver già subito deportazioni ed internamenti. La ritirata italiana determinò l’esodo di oltre un milione di profughi civili dalle province invase o sgomberate di Udine, Treviso, Belluno, Venezia e Vicenza, abbandonati dalle istituzioni statali e sovente malvisti dalle comunità italiane dell’interno.
Tale dimensione, peraltro, rende Caporetto un fatto assai vicino a quella degli esodi in atto nel nostro presente.
Altri aspetti, quasi sempre sottaciuti, di questo allargamento della guerra alla società civile, furono i bombardamenti, le distruzioni, i combattimenti e i saccheggi che colpirono alcuni centri urbani, e il fenomeno di massa dello stupro che vide vittime dei militari, non solo tedeschi e austro-ungarici ma anche italiani (secondo alcune fonti, soprattutto bersaglieri), migliaia di donne friulane, venete e slovene abitanti in zona di guerra.
Probabilmente, proprio contro queste violenze e le sistematiche angherie commesse da uomini in uniforme, si registrarono alcuni episodi di resistenza armata da parte di civili contro reparti militari di entrambi gli schieramenti.
Gli abitanti di due frazioni di Caporetto – Bergogna e Robedischis – attaccarono i soldati italiani mentre, al contrario, il 26 ottobre 1917, i giovani di Priadelis (Ud) si armarono con i fucili abbandonati dai reparti italiani e improvvisarono una difesa del paese facendo fuoco sulle pattuglie austro-ungheresi avanzanti. In Carnia e altre zone del Friuli alcuni soldati dispersi datisi alla macchia, assieme a qualche civile, si organizzarono per il sabotaggio e la guerriglia contro le truppe imperiali d’occupazione, quasi anticipando le bande partigiane di ventisette anni dopo.
Per ritrovare un filo della memoria di Caporetto, fuori dalla retorica nazionalista, non si può che seguire queste tracce e queste ombre che, da un punto di vista storico, permettono di cogliere le contraddittorie peculiarità della società italiana dell’epoca, in cui – come sottolineato da Nicola Labanca – «la classe dirigente e il suo “liberalismo” o le masse contadine e operaie e il loro “sovversivismo” si discostavano alquanto dalle loro omologhe dei Paesi dell’Intesa o degli Imperi centrali (avendo anzi tratti in comune con la situazione di quest’ultimi, o con quella di Russia, non meno che con i primi)», tanto da far realmente temere al governo uno sviluppo insurrezionale e consigliare ai vertici militari la rinuncia definitiva agli scellerati quanto vani assalti della «carne contro l’acciaio».
emmerre